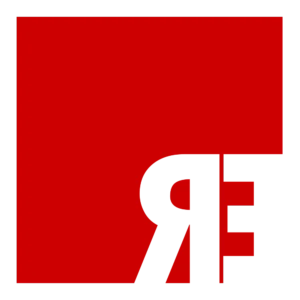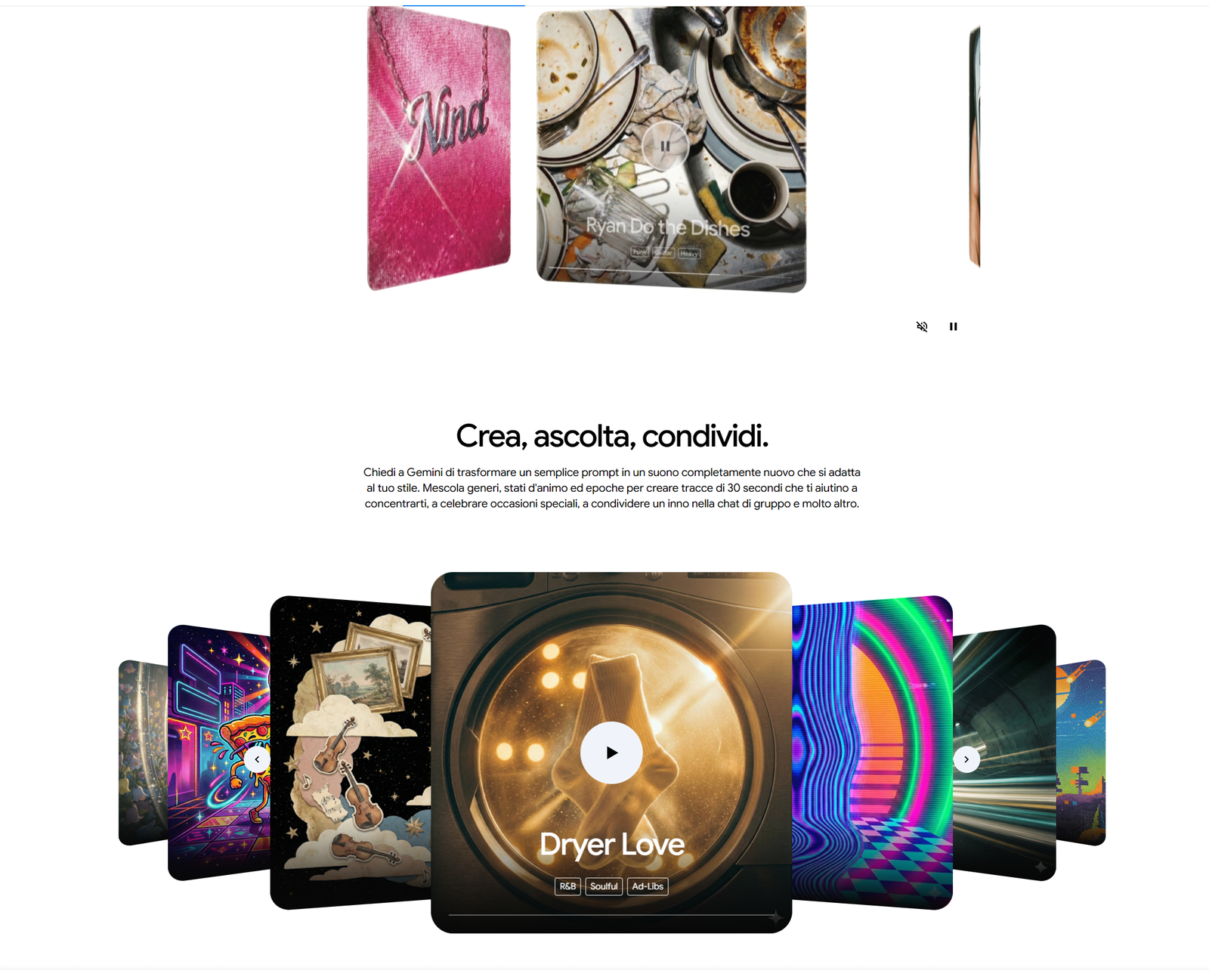di Gabriele Gobbo*
Nel mio nuovo libro Digitalogia – Non è un’epoca facile, ma è l’unica che abbiamo, dedicato alla cultura digitale, apro con un preambolo personale. Racconto un episodio semplice, umano, di quelli che lasciano il segno. Dopo averlo scritto, mi è venuta un’idea: trasformarlo in musica. Ho creato una canzone ispirata proprio a quel preambolo, da includere nel libro tramite QR code.
Ho usato un paio di tool di intelligenza artificiale: uno per scrivere le lyrics, un altro per generare la musica, con tanto di voce sintetica. Dopo diversi tentativi e aggiustamenti tramite prompt (cioè istruzioni testuali) è uscita una traccia orecchiabile, coinvolgente, persino emozionante.
E devo ammettere che mi ha stupito. Ma la sorpresa più forte è arrivata quando, in fase di revisione, ho distribuito le bozze del libro ad alcune persone senza dire nulla del QR code. Diversi mi hanno chiesto chi fosse il cantante. Tutti mi hanno detto che si erano emozionati. Nessuno ha sospettato che fosse un brano generato da una macchina.

Quel momento mi ha colpito. Da una parte, la soddisfazione di essere riuscito (pur non essendo un musicista) a creare qualcosa che funziona. Dall’altra, la consapevolezza: siamo davvero vicini al famigerato punto di non ritorno (per citare i Centory in Point of No Return). Anzi, forse ci siamo già dentro. Perché se un ascoltatore si emoziona, poco importa se dietro c’è un umano o un algoritmo. E visto che sono proprio gli ascoltatori a decidere cosa ascoltare, la vecchia giustificazione di molti producer (“l’AI non produce in qualità sufficiente”) non regge più.
Il mio saggio parla proprio di questo: di umanità e algoritmi, di etica e approccio consapevole al digitale. Non per demonizzare la tecnologia, ma per provare a renderla davvero nostra. E quell’esperienza musicale è diventata la metafora perfetta. Abbiamo già smontato gli studi, scollegato i mixer, sostituito le mani con le interfacce. Ma siamo davvero sicuri che basti un prompt per fare musica? Oppure siamo ancora in tempo per salvare l’arte (o almeno il gesto che crea l’arte)?
Io ho lavorato nella nightlife e dietro le console per 25 anni. Ho visto passare di tutto: vinili, CD, chiavette, sequencer. Perfino audiocassette registrate con la doppia piastra attaccata sotto il banco. Il cambiamento tecnologico l’ho vissuto sulla pelle. Non mi fa paura. Ma oggi è diverso. Non parliamo più solo di strumenti. Parliamo di sostituzione del gesto. Dell’intuito. Dell’errore creativo.

Oggi in console ci sono dj che non mettono nemmeno più le cuffie. Mixano con gli occhi. Leggono forme d’onda. Si affidano alla sincronizzazione automatica. La cuffia è diventata un accessorio estetico, un tocco fashion da postare su Instagram. Ma se non ascolti, se non senti, cosa stai facendo davvero?
Tempo fa ho incontrato il professor Anis Sefidanis, che ha progettato il primo robot dj di cui ho memoria. In tempi non sospetti, durante eventi e conferenze, ragionavo proprio su scenari come questi: in cui l’animazione musicale finisce nelle mani di automi, avatar digitali, o peggio ancora, deepfake in console. All’epoca sembrava una provocazione. Oggi sembra un comunicato stampa.
Come racconto in Digitalogia, ogni evoluzione ha due facce. L’AI può essere uno strumento potente. Ma va umanizzata. Non basta usarla: bisogna capirla, guidarla, decidere cosa farne. Perché se ci affidiamo solo ai numeri, se ci lasciamo sedurre dall’efficienza a tutti i costi, il rischio è uno solo: perdere la bussola.
Sostituire i deejay e i produttori con algoritmi e robot intelligenti sarà solo il primo passo. Quando la sostituzione sarà completa, passeremo al pubblico. Nelle piste, ai festival, nei live show. Avremo solo i corrispettivi cibernetici degli ascoltatori. E il cerchio sarà chiuso.
- Gabriele Gobbo è docente in comunicazione sigitale, saggista e vicepresidente del Digital Security Festival. Conduttore TV e divulgatore della cultura digitale. Intelligenza artificiale, performance senz’anima e cuffie diventate accessori. La musica elettronica è ancora arte o solo un’interfaccia?